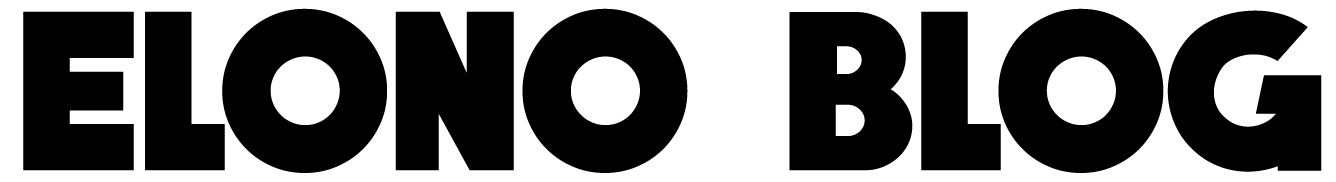Marzo è un mese particolare per l’AbanoRitz, scelto non a caso da Terry e Ida Poletto per essere dedicato a un sogno, un progetto, una realtà: la realizzazione di Super 8, che vi invitiamo, di settimana in settimana, a scoprire.
Iniziamo da Raffaele Riba, classe 83, curatore di Scrittorincittà e insegnante presso la scuola Holden. Qui come coordinatore degli autori, è proprio lui a introdurci nel mondo del Super8 con
“Benvenuti Welcome Willkommen Bienvenus”:
I nostri genitori non ci hanno mai portati in albergo quando eravamo piccoli. Tranne una volta. Le vacanze erano programmate in campeggi forniti di tende familiari, roulotte, bungalow oppure, quando era libera, affittavamo la casa a Loano di amici di famiglia. Piccolina, noi eravamo in cinque, ma andava bene perché la sera sul lungo mare c’erano bancarelle con braccialetti luminescenti, giostre a gettoni, carrelli con lo zucchero filato e altre coloratissime porcherie. Gli alberghi, così, per me sono sempre rimasti là, avvolti in quell’aria elegante e altera che non avevo mai respirato ma che immaginavo, eccome se li immaginavo, vedendo arrivare in spiaggia coloro che lì mangiavano, dormivano e vi avrebbero fatto ritorno più tardi, a prepararsi per la cena. Chissà come era vederli da dentro, gli alberghi. A giudicare i volti distesi e sereni di quelle persone, erano luoghi discreti e meno compressi del nostro – senza contare (pensavo soprattutto i primi e gli ultimi giorni) che, per arrivarci, loro avevano viaggiato senza caricare l’auto con valigie piene di lenzuola, asciugamani, provviste e tutta una serie di chincaglierie dal volume tutt’altro che trascurabile. In cinque, per i bagagli di due settimane, la nostra auto sembrava un pullman passato alla pressa di rottamazione. L’unica volta che facemmo vacanza (quattro giorni) in un albergo, avevo nove anni. Effettivamente l’auto sembrava vuota. Mio padre aveva dei problemi di sinusite e così andammo a soggiornare in una zona termale sopra le valli in cui sono nato e cresciuto. Avevamo una mezza pensione e io stavo in camera con mio fratello più piccolo, mia sorella e mia nonna. Era venuta con noi perché quando i miei facevano le cure, andavamo a spasso insieme e ci comprava la Coppa del Nonno: da mangiarsi piano, mi raccomando. Per me tutto era meraviglioso. Non so cosa mi piacesse di più. Il fatto di svegliarsi e scendere in un ristorante in cui la colazione era pronta, soltanto da mangiare, oppure non dover preparare e sparecchiare il tavolo, oppure ancora dormire in lenzuola sempre fresche e profumate. Ricordo di averlo detto alla signora del negozio di alimentari, mentre mi sporgeva il gelato, che sì: noi stavamo in albergo. Non era un granché ma ci ho pensato spesso al mio primo albergo o al suo cuoco, un signore coi baffi ingialliti dal fumo con il quale credevo di aver fatto amicizia perché una sera si era fermato a chiacchierare con me. Nonostante distasse poche decine di chilometri da casa nostra, non l’ho mai più ritrovato. Né il cuoco né l’albergo. A nove anni, dunque, sono ufficialmente entrato in quella schiera di persone che prima guardavo con curiosità e un po’ di invidia. Eppure l’esperienza non mi era bastata per avere un’idea chiara di quella specifica tipologia di alloggio dove tutti si diventava signori, dove si instaurava una sorta di democrazia della cura e del rispetto, dove potevi essere un bambino, ma volendo anche un commesso viaggiatore, un’artista in cerca di pace o uno che si curava la sinusite. Albergare è essere molte persone insieme, quelle che vuoi, circondato da altre persone che mentre fanno cena nel tavolo vicino, immagini possano essere a loro volta altre personalità e poi altre ancora; un elevare a potenza fino a raggiungere tutti i casi in cui la vita si declina. E quella specie di suggestione non doveva essere soltanto mia – pensavo ogni volta in cui mi imbattevo in un albergo tramite le storie che cominciavo a frequentare. Così l’idea di albergo man mano si è stratificata, ha acquisito nuove tessere ed è diventata sempre più nitida. Quando sono diventato adulto, gli alberghi, oltre a un ricordo lontano di uno stabile sopra Cuneo che non sapevo più dove fosse (ma poi perché non ho mai chiesto ai miei?), erano dei quadri di Hopper oppure Un giorno ideale per i pesci banana, il primo de I nove racconti di Salinger, oppure ancora L’Hotel Savoy di Joseph Roth. Letteratura ed esperienza si erano fuse e mitizzate creando semplicemente l’Albergo. D’un tratto, poi, di alberghi ho cominciato a vederne molti e in certi periodi di frequente. Uno pensa che a scrivere si veda soltanto la scrivania, ma in realtà spesso ci si sposta. E se nel frattempo la vita era cambiata – e io gli alberghi avevamo cominciato a frequentarci – non si era modificata di un millimetro quella sensazione di signorilità, un po’ discreta e un po’ sofisticata, che quegli strani luoghi infondono nelle persone che ospitano e in quelle che ci lavorano. Come se si instaurasse una sorta di simbiosi per cui i clienti scelgono l’albergo per la cura che ne possono trarre, e chi negli alberghi ci lavora impiegasse molte delle proprie energie e del proprio piacere nell’assicurare quella cura. Ancora oggi, quando entro in un albergo, mi viene automatico usare il lei, parlare con un tono di voce più profondo, scegliere i vocaboli con cura e giocare a essere me o una variante di me che pian piano si allontana da me: spesso guardo le Sale Bar e penso che sarebbe stupendo essere Jack Nicholson che ordina un Bourbon con ghiaccio a Mr. Lloyd, il miglior barman che si sia mai visto tra Timbuktu e Portland Maine, o Portland Oregon se preferite. Che classe aveva Lloyd, la classe altera degli alberghi. Era un soleggiato pomeriggio di novembre quando ho ricevuto la chiamata che mi ha portato fin qui, a pigiare 8.000 volte la tastiera per scrivere queste poche righe. Stavo su un treno, di ritorno da Roma. In aprile nove scrittori sarebbero stati ospitati dall’AbanoRitz per scrivere altrettanti racconti da raccogliere in un libro: questo (a proposito, buona lettura). Mi andava? Chiaro che sì. Non mi sembrava vero. Intanto era il miglior albergo in cui sarei mai stato e poi avrei potuto essere un soggetto di Hopper, un personaggio di Salinger o un attore diretto da Kubrik. Magari mi avrebbero dato la Camera azzurra di Simenon. Non so cosa sono stato in quei giorni (e cosa siamo stati tutti e nove) per gli altri avventori. Magari una macchia sfumata che non ricorderanno, nella fattispecie io posso esser sembrato un ubriaco che girava in accappatoio quasi a tastoni per i corridoi (in realtà non mi sono mai ubriacato ma non mi portavo dietro gli occhiali perché non lo so… accappatoio e occhiali: Lloyd non mi avrebbe mai offerto da bere); ma io vi ho osservati a uno a uno e ho immaginato tantissime cose su di voi. Non so che vita abbiate (spero con tutto il cuore che sia bella) e se vi siete domandati che vita faccia io, ma in quei giorni ho avuto la risposta che cercavo sugli alberghi: ho capito che sono come l’atomo. Una cosa vecchia come il mondo eppure con un equilibrio così forte che lo rende stabile e immortale. Ci sono gli elettroni, e quelli siamo noi, con i nostri gradi di indeterminatezza nel compiere traiettorie che orbitano intorno al nucleo. E il nucleo, l’albergo appunto, in cui ci stanno due varietà particellari strettamente interconnesse accorpate tra loro e apparentemente inscindibili, un po’ come i neutroni e i protoni. Le persone che ci lavorano, cuochi, inservienti, banconisti, camerieri e chi invece quell’albergo lo dirige, magari una famiglia, con la sua vita, la sua storia che arriva da lontano e si compie anche in quell’istante. L’ultima sera del mio soggiorno all’AbanoRitz, stavo facendo un bagno nella piscina termale. Avevo i colli Euganei alle mie spalle e da lì a poco sarei dovuto salire in stanza per prepararmi alla cena. Il tempo era fresco per cui stavo immerso quasi completamente in acqua, trentotto gradi di piacere amniotico. Appena il sole è sceso sono uscito dalla vasca ondulata, ho recuperato le mie cose e ho scattato una foto. Per ricordarmi di quel momento, di quell’esperienza, di quel tratto di orbitale che avevo percorso e che a nove anni magari avevo immaginato per la vita di qualcun altro. Ho inviato la foto su WhatsApp, al gruppo “Famiglia”. Mia madre ha risposto subito. «Bella la vita eh, ti ricordi quel buco in cui eravamo andati in vacanza a Sant’Anna di Valdieri?».

© Giovanni De Sandre