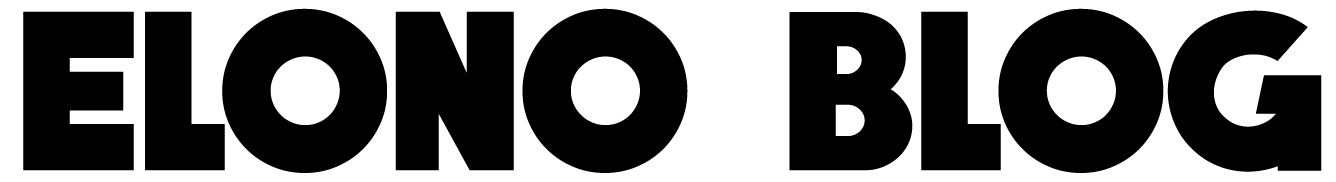Donna e giovane, la Biennale dell’Architettura bada al sodo
 L’architettura è una storia vera scritta e interpretata da esseri umani pensanti, dialoganti e possibilmente sensibili. Quelli che la progettano e quelli che la abitano. Un’utopia? No, un’ipotesi di lavoro che la prima donna architetto a dirigere una Biennale ha messo in cantiere con rigore ed eleganza. People meet in Architetture diretta da Kazuyo Sejima è una sfilata di idee, fantasie, soluzioni, e propositi molto artistici e ben poco autoritari, dotati di antenne che vibrano sulle magagne e le delizie del presente.
L’architettura è una storia vera scritta e interpretata da esseri umani pensanti, dialoganti e possibilmente sensibili. Quelli che la progettano e quelli che la abitano. Un’utopia? No, un’ipotesi di lavoro che la prima donna architetto a dirigere una Biennale ha messo in cantiere con rigore ed eleganza. People meet in Architetture diretta da Kazuyo Sejima è una sfilata di idee, fantasie, soluzioni, e propositi molto artistici e ben poco autoritari, dotati di antenne che vibrano sulle magagne e le delizie del presente.
Il tema dell’incontro è basilare. La cifra di questa Biennale Architettura è una saggia leggerezza; non c’è ottimismo ma attenzione. Niente culto della forma, spolvero galattico di archistar. Ma architetti (e artisti ad essi assimilabili per lunghezza d’onda), in massima parte giovani, che tengono in gran conto la condizione dell’uomo, della terra, delle città e si provano a rimediare sfoderando tutte le armi culturali e tecnologiche che hanno a disposizione. Molti tra loro, in ogni parte del mondo, si cimentano concretamente in progetti di recupero. L’architettura dunque come cura ingegnosa dei luoghi dove scorre l’esistenza. Non a caso la mostra alle Corderie si apre con una grande pietra solitaria in cui si può entrare e raccogliersi, nascosti e protetti come in un nido, di Radic e Correa.
Per questo il Leone d’oro alla carriera va a Rem Koolhaas, visionario concreto, principe dell’architettura come arte globale, controluce affilato della congestione della realtà che recupera la memoria anche quando è scomoda, come gli arredi nazisti dimenticati nei magazzini del museo di Monaco.
Nel mezzo una gamma varia e felicemente coerente di ipotesi. Dall’equilibrio primario di due putrelle megalitiche poggianti su una grande molla del messicano Garcia-Abril; all’atelier portato dall’India perché tutto ciò che fa architettura per Mumbai accade in quel laboratorio insediato nel luogo del progetto, dove la penuria di risorse aguzza l’ingegno e dove collaborano anche gli abitanti del posto giusto per «una condivisione diretta di conoscenza che passi attraverso l’immaginazione, l’intimità, la modestia». Parole sante, in tempo di sfrenato protagonismo e ferale consumismo, il cui senso riecheggia in molti interventi.
Aldo Cibic progetta insediamenti comunitari in aree rurali anche tra snodi autostradali per garantire a queste e a quelli una riconciliata sopravvivenza.
Fiona Tan e Kazuyo Sejima si sono intenzionalmente radicata nella minuscola isola giapponese di Inujima per creare un museo prensile dove arte e ambiente possano vivere in simbiosi.
Se l’agorà è sparita dalla scena dominata dal totalitarismo delle merci (materiali e immateriali), rimane la casa che con Andres Jaque diventa motore rigenerativo trasformandosi da luogo della dipendenza solitaria a nuvola schiumosa di frammenti di collegamento.
De Vylder Vink di case ne incastra 7, l’una sull’altra nella regione cinese della Mongolia: l’agglomerato che ne deriva accorpa la dimensione individuale e collettiva senza soluzione di continuità; mentre Sou Fujimoto studia un prototipo scomodo ma pieno di risorse se scattano relazioni inedite fra le parti.
Non manca l’incontro con l’ignoto che per gli R&Sie(n) si materializza in un osservatorio notturno in perfetto stile fantasy.