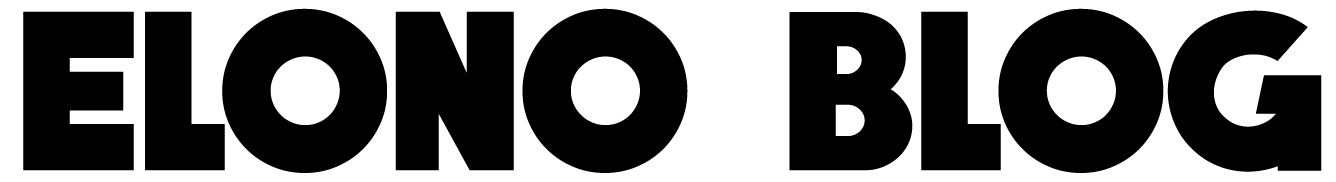Marzo è un mese particolare per l’AbanoRitz, scelto non a caso da Terry e Ida Poletto per essere dedicato a un sogno, un progetto, una realtà: la realizzazione di Super 8, che vi invitiamo, di settimana in settimana, a scoprire. Otto autori hanno soggiornato nel nostro hotel, ma più precisamente nelle stanze del quinto piano: le nostre Creative Room. Otto camere, otto scrittori, otto racconti.
Questa settimana leggiamo Alessio Arena, scrittore, cantautore e traduttore napoletano classe 84. Vince la XXIV edizione di Musicultura e il premio A.F.I. al miglior progetto discografico arrivando così, oggi, a essere autore e interprete di quattro album pubblicati tra Italia e Spagna, dove vive. Nel 2009 vince il Premio Giuseppe Giusti Opera Prima con L’infanzia delle cose (ed. Manni) e seguono poi Il mio cuore è un mandarino acerbo (ed. Zona, 2010), La letteratura Tamil a Napoli (ed. Neri Pozza, 2014) e La notte non vuole venire (ed. Fandango, 2018). Dopo averlo conosciuto, siamo convinti che non sia arrivato per caso alla camera 508 “The wood” che ci presenta con
“Mio nonno albero”
L’uomo più malvagio del mondo mi venne in sogno quando mi appisolai nel treno che mi portava a Monselice. Avevo dieci anni e, insieme a mia sorella, ero partito per i mesi di colonia estiva che offrivano ai figli degli iscritti all’Associazione Partigiani d’Italia. Nonno Peppino si era da poco spento nell’ospedale del Loreto, ma sapendo della mia imminente partenza per le vacanze, mi aveva affidato una missione, ovvero quella di far rivivere, nella fattoria che la mia famiglia affidataria aveva sui Colli Euganei, l’albero che l’uomo più malvagio del mondo aveva fatto sradicare dalla nostra loggia di via Moiariello, a Napoli. “Ricordati che si tratta di un corniolo” disse rovistando nella federa del cuscino. “Non è un albero qualunque. È quello che Ulisse e i compagni suoi usarono per costruire il cavallo di Troia”. Poi finalmente mi allungò un panno di feltro rosso e lo aprì per farmi vedere dei semi che sembravano mandorle tostate. Non capivo perché avesse aspettato quel momento per investirmi di un compito tanto oneroso, anche perché la storia dell’uomo più malvagio del mondo, come lui chiamava il comandante militare a Napoli, negli anni della guerra e dell’occupazione della città, me l’aveva raccontata mille volte. Si trattava del tenente colonnello Walter Schöll, uno spilungone con una divisa di mille medaglie, che aveva promesso l’uccisione di cento napoletani per ogni ammazzato della sua parte. Quando al decreto per il servizio di lavoro obbligatorio avevano risposto in pochissimi, lo stesso Schöll aveva organizzato ronde militari e rastrellamenti in case di mezza città per punire gli inadempienti. Nonno Peppino si era andato a nascondere nei sotterranei dell’osservatorio astronomico, vicino a casa nostra, dove il custode, un partigiano, accoglieva i giovani sovversivi del quartiere. In casa, quando i soldati nemici erano entrati, c’era solo sua madre, e pare avesse avuto talmente paura di quegli uomini che era scappata nella loggia e si era abbracciata all’unico albero della famiglia: un corniolo dal tronco leggermente più voluminoso del normale e corti rami ingialliti, dai quali penzolavano i fiori più piccoli del mondo, duri come lische di pesce. Delusi dall’aver trovato un’altra casa senza uomini, i soldati guidati da Schöll vollero punire la madre di nonno Peppino, e provvedendo subito a separarla dall’albero, rivolsero alla pianta un trattamento che non avrebbe ricevuto nemmeno il peggior nemico di Stato. Il corniolo fu prima abbattuto, sadicamente tagliato in pezzi e infine sradicato come un’erbaccia. Nei primi anni del dopoguerra, nonno diceva che sua madre non dormiva la notte, perché veniva a svegliarla la voce del vecchio albero, e la sua voce era un pianto. Per questo, nel sogno che feci quando finalmente mi appisolai nel treno, poche ore prima di arrivare alla stazione di Monselice, il malvagio Schöll veniva a rubarmi i semi che mi erano stati affidati, e io lo vedevo correre per il Moiariello mentre sosteneva il panno di feltro rosso che, da lontano, sembrava un bambino in fasce. Un bambino che piangeva come piangono i bambini quando capiscono che non torneranno più a casa. Mia sorella Margherita mi svegliò preoccupata. Visto che stavo sudando, chiese il permesso per aprire il finestrino del vagone, e dopo avermi asciugato la fronte con un suo fazzoletto che odorava di canfora, mi invitò a guardare la campagna, che fuori si illuminava man mano che il treno perdeva velocità. Tutt’attorno era bianco, come se ci stessimo muovendo in un banco di nuvole. Ma qui e lì facevano capolino piccoli borghi, ville accerchiate da boschi di faggi, e alcune chiese dove immaginai andassero a pregare solo gli uccelli rapaci. “È vero che il mare non ci sta” disse mia sorella, spettinandomi. “Però sono belli questi colli, come i faraglioni di Capri”. Arrivati in stazione, io e Margherita leggemmo i nostri nomi disegnati su un cartello dietro il quale si nascondeva un bambino della mia età. Quando ci avvicinammo, lui sorrise e ci disse che i suoi genitori aspettavano nella macchina, appena fuori la stazione. Quel primo giorno a Fontanafredda, il piccolo borgo dove la famiglia che ci ospitava si era costruita una casa in mezzo ai vigneti, capii che quei signori si erano messi a disposizione per il programma di colonie solo per far piacere a Giulio, il bambino che non mi lasciò solo nemmeno per un attimo. Aveva le orecchie a sventola e dei capelli rossi lunghissimi che raccoglieva in un codino nascosto nel collo della maglietta. I genitori raccontarono che Giulio ebbe un male molto serio appena nato, nel giorno di Sant’Agnese, e che per averlo salvo avevano fatto un voto alla santa. Mentre andavamo in cerca di ricci che puntualmente lasciavamo sul lettino di Margherita, per farla spaventare, ma anche per cercare di intrattenerla, Giulio mi raccontava le storie di santi che i suoi genitori gli avevano insegnato. Soprattutto quella della sua protettrice, che essendosi rifiutata di sposare un patrizio romano, fu costretta a camminare nuda per le strade di Roma. “Però lei si mise a pregare” mi confidò, “e per miracolo i suoi capelli diventarono lunghissimi, fino a coprirle tutto il corpo”. I genitori di Giulio ci lasciavano liberi di girare nei campi attorno alla casa, dove io studiavo il terreno e in segreto immaginavo il posto migliore dove sotterrare i semi di nonno Peppino. Poi un giorno Margherita si alzò con la schiena dolorante e si lamentò di essere capitata dove non faceva altro che scrivere lettere ai suoi fortunati compagni di classe, in vacanza sulle affollate spiagge di Ischia. Allora decisero che ci avrebbero portati in un vicino albergo termale. “Andiamo ad Abano” disse la madre di Giulio facendo scroccare il collo con una certa violenza. “Lì ci sono dei fanghi che sono una vera magia”. Partimmo per una settimana. Giulio mi aveva assicurato che all’AbanoRitz, l’hotel che già altre volte li aveva ospitati, c’era tantissimo spazio dove giocare a nasconderci, avremmo avuto una grande piscina a disposizione, una stanza tutta per noi, e un giardino pieno di alberi dove i conigli selvatici tenevano i loro nidi. Fu forse questo ultimo dato a convincermi di portare con me il panno di nonno Peppino e, almeno così pensai allora, fu il mio unico grande errore. Venni a sapere che al quinto piano ci vivevano i padroni, e soprattutto la loro figlia, che aveva la nostra età. Giulio non l’aveva mai incontrata, ma gli avevano detto che amava tanto la natura, che nel giardino stavano per costruirle una casa su un albero. Fu in quel momento che mi resi conto di non avere più i semi. Tornai di corsa nella nostra stanza e cercai in ogni tasca, nelle pantofole, negli armadi, sotto ai letti, ma niente: il panno di feltro rosso era sparito. Quando ne parlai piangendo alla madre di Giulio, mi rassicurò che era impossibile perdere qualcosa in quell’albergo. Eppure nessuno seppe darci una risposta e io mi misi in testa che solo la bambina che viveva nell’albergo avrebbe potuto aiutarci. Il caso, però, si era messo contro di noi e venimmo a sapere che Ilaria – si chiamava così – aveva preso la varicella ed era ovviamente impossibile andare a visitarla al quinto piano. La nostra vacanza finì due giorni dopo quel colpo al cuore che io non ero capace di spiegare ai genitori di Giulio, e il resto del soggiorno a Fontanafredda furono soltanto una serie di brutti sogni in cui Schöll mi allungava la cornetta di un telefono rosso e io sentivo piangere l’albero di nonno Peppino. Per fortuna arrivò presto il momento di tornare a Napoli, e con il tempo cercai di dimenticare quell’infelice episodio. Negli anni, però, mantenni una corrispondenza più o meno regolare con Giulio, che mi raccontava dei successi a scuola e poi all’università, delle ragazze e dei suoi continui ritorni all’AbanoRitz, dove non aveva mai smesso di cercare il mio panno di feltro. Pur non avendomi mai chiesto cosa contenesse. Anch’io gli scrivevo, immaginando che un giorno o l’altro avrei rivisto il mio improvvisato amico del cuore. Poi Giulio mi raccontò un fatto inverosimile: si sposava, e lo faceva con Ilaria, la misteriosa bambina che viveva nell’hotel. Mi raccontava che era bella, anche se aveva le orecchie come le sue, mal celate da un simpatico caschetto di capelli biondi. Non riuscii ad andare su per il loro matrimonio, perché nel frattempo mi ero trasferito da solo e avevo cominciato a lavorare alla facoltà di Agraria come assistente, ma guadagnavo poco e di viaggi non ne facevo. Poco dopo le nozze, Giulio, che era ormai un architetto, raccontò che mentre ristrutturavano la loro casa nel ghetto di Padova, era andato a vivere all’AbanoRitz con Ilaria. E mi mandò una foto in cui stavano seduti con un cesto di vimini, pieno di piccoli frutti rossi, appoggiato sulle gambe. “Queste sono corniole” scrisse. “Le sorelle sofisticate delle ciliegie. Ogni primavera spuntano in abbondanza da un piccolo albero del giardino dell’hotel”. Trattenni il fiato. Anche da lontano potevo sentire il profumo di mio nonno albero. O forse pure il cuore mio, in quel preciso istante, era diventato un piccolissimo frutto rosso.

© Giovanni De Sandre