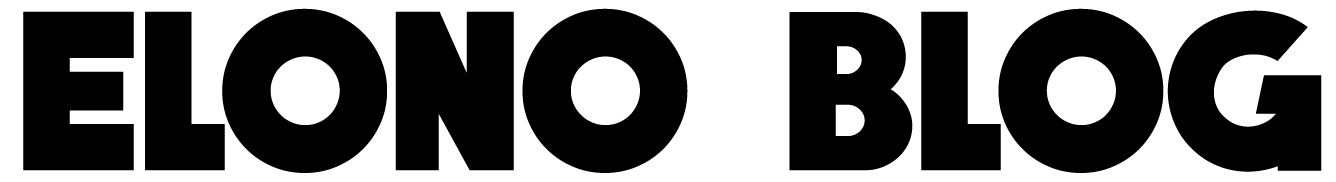Marzo è un mese particolare per l’AbanoRitz, scelto non a caso da Terry e Ida Poletto per essere dedicato a un sogno, un progetto, una realtà: la realizzazione di Super 8, che vi invitiamo, di settimana in settimana, a scoprire. Otto autori hanno soggiornato nel nostro hotel, ma più precisamente nelle stanze del quinto piano: le nostre Creative Room. Otto camere, otto scrittori, otto racconti.
Questa settimana leggiamo Mari Accardi, classe 77, palermitana di nascita e al momento in Francia. La rivista Granta Italia l’ha nominata tra le voci più promettenti del Paese. Ha esordito con il romanzo Il posto più strano dove mi sono innamorata (ed. Terre di mezzo, 2013) e il suo ultimo libro risale al 2018: Ma tu divertiti (ed. Terre di mezzo). E per divertirla noi abbiamo pensato alla camera 514 “Swan” che ci presenta con
“Cosa conservare in una scatola”
I saluti erano cominciati una settimana prima, e al momento di partire il mio fidanzato non arrivava. Lo aspettavo in sala lettura, da sempre un rifugio non troppo nascosto, tra l’ingresso e la hall. Alla hall davo le spalle: dopo gli addii mi sentivo un’ombra, qualcuno a cui quel luogo non apparteneva più. Per la prima volta, dopo vent’anni, mi sentivo un’ospite. Sotto la mensola del caminetto c’era ancora il mio nome inciso con la chiave: Otavia – all’epoca in cui l’ortografia era un gioco come un altro. Mi rilassava passarci sopra il dito. Dovevo essermi addormentata e quando ho riaperto gli occhi un husky stava annusando le valigie. Assomigliava a un peluche con cui dormivo da bambina, prima che il letto se lo mangiasse (così mi avevano raccontato). Capitava che i clienti portassero i propri cani, di rado i gatti. Occasionalmente pappagalli, criceti e una volta persino una tartaruga. L’accoglienza era uguale per tutti. Ho provato ad accarezzarlo ma lui ha indietreggiato. Aveva un collare rosso, senza targhetta, dal quale penzolava una catena spezzata. “Vieni qui, bello.” Lui continuava a indietreggiare finché non è uscito dalla stanza. Il mio fidanzato era ancora irraggiungibile. Fuori ormai era buio e con la pioggia non si distinguevano i contorni. Ho preso la scatola che fino ad allora avevo tenuto in cassaforte – dentro c’erano perlopiù foto, lettere, cartoline, segreti ingenui – e sono rientrata nella hall in punta di piedi. A quell’ora il ristorante stava chiudendo e un musicista in abito grigio suonava la Bossa Nova al pianoforte per una coppia di tedeschi che ballava a un ritmo più lento. Era tutto rallentato sul finire della stagione. Mi guardavo attorno ma l’husky non c’era. “Non vuole lasciarci, vero?” ha detto Glauco, spuntato da dietro con un vassoio di bicchieri vuoti. Alle elementari mi aiutava con le tabelline e le poesie: io sopra lo sgabello, lui dietro il bancone del bar. Eppure continuava a darmi del Lei. Il nostro addio si era ridotto a una stretta di mano. “Forse sono stata abbandonata.” Glauco aveva assistito a tutti i miei amori, corrisposti e non. A cominciare dal ragazzino di Lugano, a dodici anni, con cui giocavamo in silenzio. Un giorno mi aveva dato un bigliettino (che adesso era dentro la scatola): “Ciao, mi chiamo Andrea. Sei carina”. E il giorno stesso, sempre in silenzio, aveva preso col polpastrello una ciglia che mi era caduta e ci aveva soffiato su. Non ci eravamo più rivisti. Anche il mio fidanzato si chiamava Andrea. Non era un cliente ma un sous-chef. In ascensore aveva raccolto un’altra mia ciglia e avevo sentito l’euforia delle coincidenze (la ciglia gli era rimasta attaccata al polpastrello e l’avevo messa nella scatola). L’avrei amato lo stesso se non si fosse chiamato Andrea? Se avesse fatto un altro gesto? “C’è un husky che gira impaurito per l’hotel. L’hai visto? Dev’essere scappato da non so dove.” “Non me ne sono accorto.” Glauco mi ha sorriso, gli ho porto la mano per un secondo saluto (o forse il terzo) e ha esitato prima di stringerla. Poi l’ha presa tra le sue, il corrispettivo discreto di un abbraccio. Tutti i miei amori erano nati in quell’hotel perché era la mia casa, il mio mondo. Quando i miei genitori avevano divorziato, le mie sorelle erano andate con mia madre, i gemelli con mio padre e io, la più piccola, ero stata mandata lì, dai nonni. “Temporaneamente”. Fino alle medie evitavo di dare l’indirizzo, mi vergognavo a dire che mangiavo al ristorante, che non avevo mai rifatto un letto. Mi chiamavano “la principessa”. Sono salita al primo piano. A destra c’erano le piscine, da dove stavano uscendo gli ultimi clienti. “Avete visto un husky?” ho chiesto. Loro scrollavano le spalle. I nonni avevano passato in acqua metà delle loro giornate, mentre io avevo imparato a nuotare tardi – come per tutto – alle superiori, quando le mie compagne cercavano scuse per farsi invitare. Studiavamo sulle sedie a sdraio, in accappatoio, bevendo succhi di frutta poi sostituiti da acqua tonica e al quinto anno da birre, nascoste in giardino. Finalmente la mia diversità si era rivelata un vantaggio. Quando andavo a trovare i miei le loro case ormai erano gabbie, mi mancava l’aria. Con Andrea avremmo abitato in un appartamento che aveva almeno il giardino. Era piccolo per me – qualsiasi spazio per due lo sarebbe stato – ma era un compromesso. Ed è questo che si fa in coppia, giusto? Si trova un compromesso.
Ho girato a sinistra verso le camere. Capitava che le donne delle pulizie, a volte, mi lasciassero entrare. Cercavo oggetti dimenticati, termini di paragone con la camera dei nonni, messaggi. Finita la scuola avrei dovuto trasferirmi in un collegio universitario. Nel frattempo, però, il nonno era morto e non me l’ero sentita di lasciare la nonna da sola. Passando accanto alle porte chiuse sentivo bisbigli, mentre da sotto arrivavano le note di Águas de Março. Aveva smesso di piovere e dalla finestra del corridoio iniziavano a distinguersi i fari delle poche macchine. Sono salita al secondo piano, a occhi chiusi. Era un gioco che facevo da bambina: girare per l’hotel bendata senza inciampare o sbattere. Prendevo l’ascensore, pigiavo su un tasto a caso e ovunque mi trovassi cercavo di orientarmi. Ci sono un’infinità i giochi che si possono fare da soli. Una ragazza all’incirca della mia età batteva alla porta di una camera. Diceva: “Lo scherzo è durato troppo, adesso fammi entrare”. Aveva un tubino nero e le pantofole. Da dentro si sentiva ridere. Ha iniziato a ridere anche lei, continuando a battere. La porta però restava chiusa. Ho sentito il tintinnio di una catena provenire da sopra e sono corsa al terzo piano e poi al quarto, dove le luci erano fioche e in un attimo si sono spente. Un cameriere del ristorante camminava a passi veloci verso di me. Distinguevo i guanti bianchi. “Avviso subito la reception” ha detto, come se ancora vivessi lì. Tutti i camerieri, per salutarmi, si erano tolti i guanti. Un gesto che mi commuoveva. L’avrei espressa così la gentilezza.
In fondo al corridoio c’era l’acquario, l’angolo più romantico dell’hotel. Quando un ragazzo mi piaceva facevo in modo di portarlo lì. Una sorta di primo appuntamento. Dai movimenti dei pesci capivo se era quello giusto o no. Un codice che mi ero inventata nei miei giochi solitari. Qui con Andrea ci eravamo dati il primo bacio. Qui, due anni dopo, mi aveva detto che aveva trovato un lavoro in un’altra città e avrebbe voluto che andassi con lui. E poi la nonna era morta e la camera sarebbe tornata all’hotel, a meno che non l’avessi presa io. Andrea mi aspettava, i miei fratelli si erano fatti una famiglia, il “temporaneamente” era giunto alla fine. Uno dei pesci era immobile al centro della vasca. Se era morto, Andrea non sarebbe venuto. Durante l’adolescenza mi dicevo che se dall’ascensore fosse uscito qualcuno vestito di giallo – o di arancione, di viola – sarebbe successo questo o quello. Se fosse apparso un fulmine in un giorno assolato, i quadri dei corridoi avessero cambiato di posto, la radio avesse trasmesso quella determinata canzone… Me lo inventavo così il mio destino. Il pesce era fermo e nessun husky in giro. Forse me l’ero immaginato nel dormiveglia. Ma poi l’ho sentito di nuovo, il tintinnio della catena, e sono salita al quinto piano, l’ultimo, e ho camminato a occhi chiusi, sperando stavolta di inciampare. E lui era lì, accucciato davanti alla mia camera, di cui non avevo più le chiavi. Adesso si lasciava accarezzare. E mentre il cellulare squillava, insistentemente, io mi sono seduta accanto a lui.